Riserve integrali tra conservazione e soluzioni condivise

Mount Live ha deciso di avviare una inchiesta partecipata sulle Riserve Integrali, zone off-limits che insistono in molti Parchi del territorio nazionale. Negli ultimi tempi tali Riserve hanno aperto un dibattito serrato tra i fruitori della montagna con posizioni divergenti in merito. Mount Live, quindi, darà voce e spazio a coloro che vorranno dire la loro. Inviate il vostro contributo all’indirizzo mail redazione@mountlive.com
 Molti dei Parchi Nazionali e Regionali sono stati istituiti attraverso la “legge quadro n. 394 del 1991”, con l’obiettivo di coniugare le esigenze di conservazione e tutela del patrimonio naturale con gli interessi delle popolazioni locali. Il Piano del Parco, poi, suddivide il territorio in funzione del diverso grado di protezione. In particolare alcuni parchi hanno al loro interno le zone A, dove la protezione dell’ambiente, fauna e flora è in forma integrale, vale a dire che le misure adottate sono molto restrittive.
Molti dei Parchi Nazionali e Regionali sono stati istituiti attraverso la “legge quadro n. 394 del 1991”, con l’obiettivo di coniugare le esigenze di conservazione e tutela del patrimonio naturale con gli interessi delle popolazioni locali. Il Piano del Parco, poi, suddivide il territorio in funzione del diverso grado di protezione. In particolare alcuni parchi hanno al loro interno le zone A, dove la protezione dell’ambiente, fauna e flora è in forma integrale, vale a dire che le misure adottate sono molto restrittive.
Nel Parco nazionale della Majella, ad esempio, nelle zone A l’obiettivo prioritario è quello di garantire i massimi tassi di riproduzione e sopravvivenza delle specie animali di particolare interesse e le misure restrittive, oltre a limitazioni nel pascolo, riguardano la regolamentazione di accesso in alcuni siti.
Nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la riserva integrale è un territorio che per le sue caratteristiche faunistiche, floristiche, geologiche merita conservazione assoluta. Vige così il divieto di alterazione dell’ambiente, l’accesso dei visitatori è consentito solo a piedi, lungo itinerari prefissati, preferibilmente con l’ausilio di Guardie o Guide del Parco. La Riserva Integrale della Camosciara si distingue anche per il suo aspetto e per la struttura dolomitica; è presente, infatti, la dolomia, un tipo di roccia che, essendo impermeabile, permette all’acqua di scorrere in superficie dando luogo a pittoresche cascate e pozze d’acqua. Questo Parco, il più antico in Abruzzo, è stato di fondamentale importanza per la conservazione di alcune specie, tra cui orso bruno marsicano, camoscio d’Abruzzo e lupo la cui presenza si segnala anche sulla vicina Majella, e i suoi boschi permettono la presenza di specie animali molto rare, come il picchio di Lilford.
Purtroppo distruggere è facile e tornare alla normalità di tempi lontani è un lungo cammino e non si può abbassare la guardia.
In particolare l’Orso Marsicano da solo varrebbe tutta la riserva e anche se è ancora una specie a rischio, alcuni esemplari si ritrovano anche nel Parco della Majella e sull’appennino abruzzese in genere.
L’Orso, al contrario di quanto si possa pensare data la sua stazza, è una specie il cui ciclo vitale e riproduttivo è delicato. La femmina dell’orso può avere gravidanze ogni circa 3 anni, dato che si occupa della prole dalla nascita per circa due anni. Il successo riproduttivo dipende anche da quanto la femmina, durante il periodo da maggio a novembre, riesce a mangiare per poter affrontare l’inverno. Infatti, nonostante l’accoppiamento avvenga in primavera, i piccoli nascono in gennaio poiché, come altri in altri mammiferi, l’uovo fecondato nei primissimi stadi di sviluppo va in una specie di letargo, “ la diapausa embrionale” dalla quale esce solo quando la madre ha accumulato sufficiente grasso per il letargo e l’allattamento. Anche per questo motivo gli orsi attraversano il periodo di iperfagia nel quale cercano di accumulare grasso il più possibile e per questo si spingono nei centri abitati provocando danni e paure. La riserva, ovviamente, serve anche a distogliere gli animali dai centri abitati e con l’aiuto delle popolazioni residenti e l’uso di recinti elettrici si cerca di venire incontro alle esigenze di tutti.
Arrivato l’inverno gli orsi si ritirano nelle tane. Generalmente le tane sono ricavate in piccole grotte naturali, a volte allargate ed adattate dall’orso, più raramente vengono direttamente scavate nel terreno. L’ingresso è spesso poco visibile e di dimensioni ridotte rispetto alla mole dell’animale. Durante lo svernamento il plantigrado cade in un profondo torpore, la temperatura corporea si abbassa, il metabolismo rallenta e l’animale consuma lentamente le scorte di grasso che ha accumulato nel corso dell’autunno. Il letargo non è però assoluto, a volte l’orso può uscire dalla tana per brevi periodi, nelle ore più calde della giornata. Se disturbato l’animale abbandona il ricovero ed è costretto a reperirne uno d’emergenza, dove però i piccoli non arrivano facilmente e l’orsa può arrivare ad abbondonarli a morte certa.
Ma molti altri animali sopravvivono ora grazie ai parchi: l’ultimo esemplare di camoscio nel massiccio della Majella fu abbattuto nell’Ottocento, analogamente a cervo e capriolo. L’orso, ridotto a pochi esemplari, è riuscito a sopravvivere in condizioni precarie nelle foreste più impenetrabili, così come la lontra. Solo il Lupo, soprattutto per l’abbondanza di greggi e la maggiore capacità di adattamento è sfuggito all’annientamento. Il Camoscio d’Abruzzo, è ora tornato signore incontrastato delle vette e praterie d’alta quota ed assieme all’altra fauna e la ricchissima vegetazione contribuisce a ricreare un ecosistema ideale per altre specie.
Sulla Majella, inoltre, il piano alpino occupa una superficie molto estesa ed occupata dalla mugheta, cioè boschi di Pino Mugo. Il Pino mugo è molto comune sulle Alpi centro- orientali e su gran parte dei massicci montuosi centro europei. Sull’Appennino è quasi assente e la Majella è l’unica eccezione: questa montagna ospita infatti delle pinete a pino mugo estese per centinaia di ettari, come era un tempo e cioè prima dei disboscamenti e diquando l’attività pastorizia aveva ridotto l’estensione della mugheta. Tutti i pendii utilizzabili per il pascolo vennero disboscati e la mugheta è sopravvissuta solo nei versanti più scoscesi e irraggiungibili. Il pino mugo è utilizzato nell’industria farmaceutica per l’estrazione del mugolio, principio attivo dalle spiccate proprietà balsamiche, nel giardinaggio come pianta ornamentale, ma soprattutto si è dimostrato utile per consolidare i pendii instabili e per trattenere gran parte della neve eliminando o riducendo notevolmente il rischio di valanghe.
Informarsi dunque è fondamentale per capire e anche per poter interloquire con i ricercatori e le dirigenze dei Parchi per confrontarsi e trovare soluzioni condivise.
Giusi Pitari
Appenninista/Docente Università degli Studi dell’Aquila
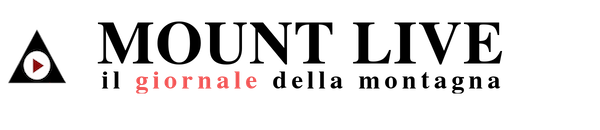






Le riserve integrali sono una limitazione che non serve e contro i diritti dell’uomo, all’uomo non deve mai essere vietato l’accesso a nessun posto, limitare gli spostamenti sui soli sentieri è una violenza